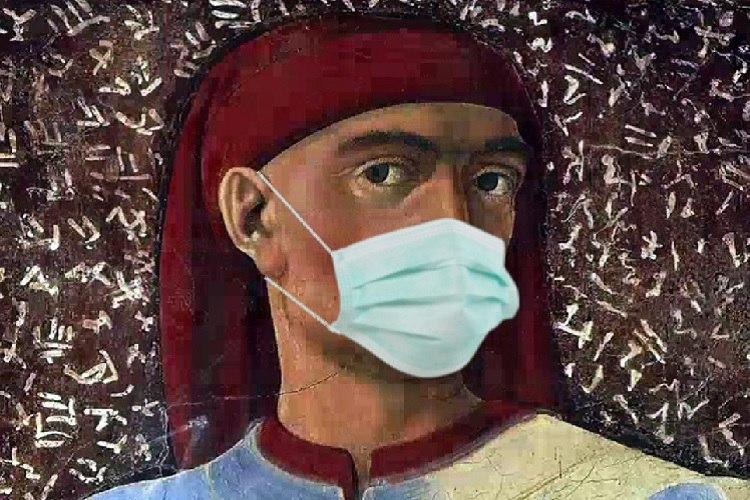Chi è genitore o insegnante conosce bene la lotta quotidiana contro l’uso indiscriminato, continuo, ossessivo del cellulare da parte di bambini e ragazzi dai sei anni in su (talvolta anche da prima).
Non c’è genitore che in un impeto di rabbia non abbia desiderato distruggere l’odiato oggetto che, gli occhi dei giovani commensali fissi sullo schermo, rende ormai silenziosi i pasti in famiglia, isola i figli nelle loro stanze, talvolta li barrica nel bagno per sfuggire ai controlli; la sera costringe molti degli appartenenti a generazioni più anziane, ancora legati a quel vecchio arnese che è la televisione, a seguire le trasmissioni con le cuffie per non disturbare le conversazioni telefoniche.
Il cellulare, legato quasi da un cordone ombelicale, è una protesi di cui non si può più fare a meno: da alcuni già sfoggiato al polso, con il veloce progresso dell’innovazione tecnologica possiamo immaginarlo a breve incorporato al palmo della mano.
La dipendenza che induce non va tuttavia liquidata con un giudizio troppo frettoloso e inappellabile.
L’avversione che madri, padri, educatori nutrono potrebbe venire mitigata da alcune considerazioni che portano a rivalutare il ruolo del cellulare per coloro che affrontano quella fase avventurosa e tumultuosa della vita che è l’adolescenza.
Una stagione in cui per la prima volta affrontano il pensiero della morte, con le paure e anche l’attrazione che questa comporta. La connessione continua diventa allora una difesa dal senso di solitudine che non si è pronti ad affrontare.
Mi attraversa la mente un’ardita analogia.
Freud osserva il gioco del nipotino Ernst (18 mesi), il quale lancia lontano da sé, facendolo scomparire, un rocchetto che poi recupera con vocalizzi gioiosi grazie a un filo ad esso collegato, e lo interpreta, in una celebre pagina di Al di là del principio del piacere, come un rituale per esorcizzare la paura dell’assenza della madre. Nel gioco il bambino “metteva in scena” il suo sparire e ricomparire. Il rocchetto perduto e ripreso lo rassicurava e lo aiutava a imparare che, anche quando era fuori dal suo campo visivo, la madre non era perduta per sempre, continuava a esistere in un altrove, e sarebbe tornata, richiamata dal filo invisibile che la legava a lui.
È possibile che il cellulare svolga una funzione simile a quella del rocchetto, ovvero protegga il ragazzo dall’angoscia della solitudine, dalla paura di venire abbandonato dagli amici, ma contribuisca anche a svezzarlo, donandogli la certezza del filo nascosto che lo lega agli altri.
Quando si sentirà sicuro di continuare a occupare la mente e gli affetti altrui, allora sarà in grado di superare la sua dipendenza, di non essere più schiavo della connessione, ma di decidere liberamente se e quando attivarla o interromperla.
C’è infatti una cosa che accomuna giovani e meno giovani: tutti desideriamo sentirci pensati.